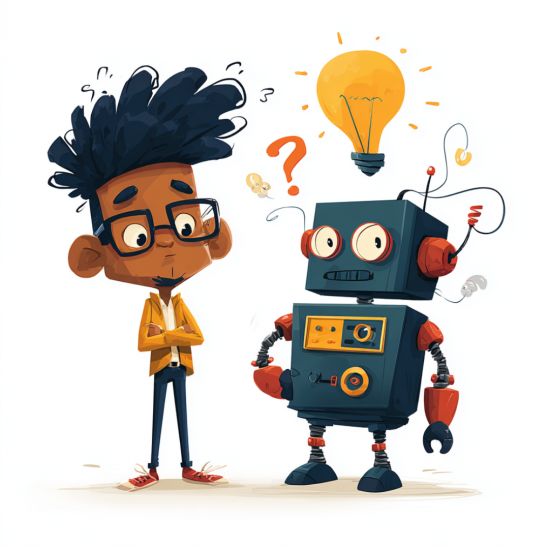L'innovazione secondo Sherlock Holmes
Chi di noi non ricorda il grande Sherlock Holmes, il geniale detective nato dalla penna di Arthur Conan Doyle, che da un’attenta osservazione ed analisi di tutti i piccoli dettagli che incontrava sulla scena del crimine riusciva a risolvere i casi più impossibili.
Questa sua capacità di ragionamento, nella logica, prende il nome di ragionamento abduttivo, qualità indispensabile per chi fa parte di un team di innovazione. Perchè? Scopriamolo insieme!
Il ragionamento abduttivo è una forma di ragionamento logico formulata e strutturata dal filosofo americano Charles Sanders Peirce a partire dall'ultimo terzo del XIX secolo che va ad integrarsi ai ben più noti ragionamento induttivo e deduttivo.
Il design thinking, ad esempio, utilizza il metodo abduttivo nella sua capacità di porsi a metà tra pensiero analitico e intuitivo.*
Un percorso di innovazione è un percorso dove si costruisce conoscenza. Tutte e tre le inferenze possono accrescere il nostro livello di conoscenza (induzione e abduzione necessitano però di una verifica sperimentale), ma è solo grazie all’abduzione che possiamo formulare idee nuove verso le quali indirizzare il nostro percorso di validazione del problema da risolvere.
Facciamo un passo indietro ed analizziamo nel dettaglio questi strumenti.
Osserviamo il seguente schema:
La macchina non parte (ipotesi/caso concreto)
Se non c’è benzina la macchina non parte (regola)
Non c’è benzina nella macchina (risultato)
Deduzione: da una regola ed un caso otteniamo un risultato.
* Regola: Se non c’è benzina la macchina non parte
* Ipotesi/Caso: La macchina non parte
* Risultato: Non c’è benzina nella macchina
Sono noti una condizione (un caso o un’ipotesi) ed una regola, da cui otteniamo delle conclusioni.
Induzione: da un caso e da un risultato concreto proviamo a definire una regola:
* Ipotesi/Caso: La macchina non parte
* Risultato Non c’è benzina nella macchina
* Regola: Se non c’è benzina la macchina non parte
Ripetute osservazioni sulla coesistenza di una condizione preliminare e di una conclusione ci possono far determinare una regola.
Abduzione: da un risultato concreto, considerando una regola possiamo determinare un caso:
* Risultato: Non c’è benzina nella macchina
* Regola: Se non c’è benzina la macchina non parte
* Ipotesi/Caso: La macchina non parte
Analizziamo meglio questo ultimo blocco. Si inizia con un'osservazione o un insieme di osservazioni che, in base a delle regole che già conosciamo, ci aiutano a formulare un’ipotesi che possa spiegare il risultato che abbiamo osservato.
A differenza del ragionamento deduttivo, dobbiamo però necessariamente verificarlo. Come nel caso del medico che osservando i sintomi del paziente e, in base alle conoscenze ed esperienze pregresse, può ipotizzare una diagnosi che spieghi la causa del problema.
Cosa faceva Sherlock Holmes?
Il detective londinese, così come tutte le indagini penali ed i processi risultanti, fa affidamento su questo tipo di ragionamento inferenziale: tutte le conclusioni rispetto alla possibile dinamica del reato sono tratte dalle prove.
Come ci può essere utile nella gestione dell’innovazione?
L’abduzione è un utile strumento che ci consente di ipotizzare che un particolare possa contribuire ad identificare un problema da risolvere, partendo da quello che Clayton Christensen chiamava il jobs to be done, un'affermazione che descrive nel dettaglio ciò che un gruppo di persone sta cercando di raggiungere o realizzare in una determinata situazione, un compito, un obiettivo, una difficoltà da risolvere o qualcosa da evitare.
Il jobs to be done può rappresentare il risultato concreto che abbiamo osservato. A questo punto, in base alla nostra esperienza e conoscenza ci affidiamo ad una regola (meglio un principio di funzionamento) per giungere ad un’ipotesi, che possa identificare il problema o meglio la causa/il meccanismo che crea un problema in una determinata situazione. Da questa ipotesi possiamo poi procedere alla fase di nuova sperimentazione per verificare se il problema è stato ben verificato e passare quindi alla fase di prototipazione della soluzione.
Il punto interessante è che tutte le interpretazioni nascono da noi e dal modo in cui le osserviamo. Quindi se, da un lato, alimentando e sviluppando la nostra creatività possiamo formulare ipotesi migliori, al tempo stesso dobbiamo considerare che l’ipotesi da noi formulata (a differenza del ragionamento deduttivo) deve essere necessariamente verificata. Dobbiamo testarla e verificarla (meglio ancora se utilizziamo un prototipo di quella che sarà la soluzione definitiva) ed in basi ai dati ed i risultati raggiunti, capire se può essere una soluzione valida, sostenibile e fattibile per risolvere il nostro problema.
Come sviluppare quindi la nostra capacità di abduzione?
"Elementary, my dear Watson..."
Allarghiamo il nostro orizzonte di conoscenza: Gli innovatori e le organizzazioni innovative possono intercettare nuovi trend ed opportunità monitorando con attenzione ciò che accade al di fuori dei confini aziendali e della loro attenzione quotidiana. La creazione del valore dipende in larga misura dalla qualità delle nostre connessioni e relazioni e, soprattutto, dalla qualità della conoscenza (anch’essa integrata) dei nostri clienti, dei nostri partner, le informazioni a cui posso accedere grazie a nuovi strumenti, tecnologie, al marketing. Sherlock Holmes conosceva di tutto, dalla chimica, anatomia, letteratura, politica, musica (suonava abilmente il violino).
Circondiamoci di persone a T: Utilizzare linguaggi diversi, coniugare visioni concettuali diverse e discipline complementari forniscono strumenti utili ad affrontare complessità e incertezze. Discipline olistiche ed umanistiche, integrate a conoscenze tecniche, ci aiutano ad essere maggiormente consapevoli di come impiegare efficacemente le nostre risorse e costruire valore con chi ci circonda e soprattutto come Sherlock ci permettono di creare connessioni tra idee, schemi, concetti, prospettive appartenenti a discipline diverse.
Costruiamo modelli per semplificare i concetti: per poter ricordare meglio e soprattutto organizzare la conoscenza in un modello di semplificazione, Sherlock usava il palazzo della memoria: una tecnica di origini greche per strutturare e visualizzare all’interno di un luogo complesso una serie di ricordi così da aumentare la nostra capacità e la facilità di ricordare anche i dettagli più specifici.
(cfr. Rino Panetti Theory U, Learning Organizations e Design Thinking; e cfr. Metodologia RID)