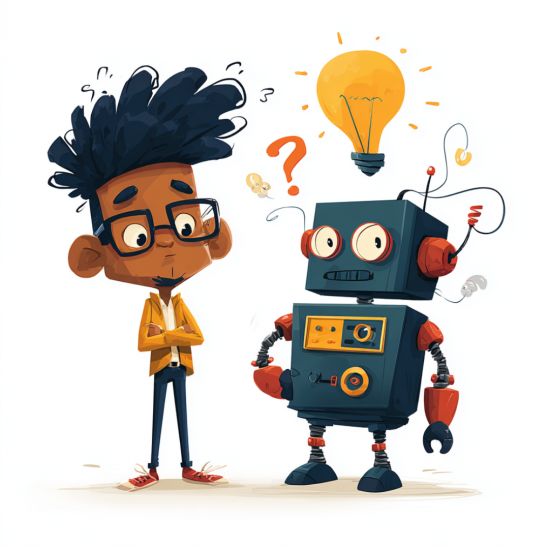Il metodo al contrario: co-creare sistemi che apprendono
Stiamo progettando sistemi che ci aiutano a pensare, o che pensano al posto nostro?
Nell’era degli agenti artificiali, dove la conoscenza si accumula più rapidamente di quanto gli esseri umani possano elaborarla, diventa urgente ridefinire il rapporto tra dato, informazione e azione.
L’autore Andrea Tiveron ha descritto con lucidità come il futuro del Business Process Management (BPM) non possa più limitarsi alla logica della misurazione o dell’efficienza, ma richieda un pensiero sistemico capace di osservare i flussi informativi nel loro insieme.
Tiveron sottolinea che un dato resta tale finché non genera un’azione. Solo quando un agente (umano o artificiale) agisce, il dato diventa informazione. È un passaggio chiave: l’informazione non è ciò che “possediamo”, ma ciò che trasforma.
Dalla standardizzazione alla danza con la complessità
Nel suo articolo, Tiveron denuncia il rischio della standardizzazione dei processi come risposta automatica alla complessità.
L’automazione spinta tende a irrigidire i sistemi invece di renderli adattivi. Ma la realtà in cui operano oggi le organizzazioni non è semplice né lineare: è un sistema vivo, interconnesso, dove ogni azione genera effetti non sempre prevedibili.
Qui entra in gioco il pensiero sistemico, contrapposto alla visione riduzionista che ancora domina la cultura manageriale.
Non possiamo comprendere un sistema scomponendolo in parti: serve imparare a leggere le relazioni tra le parti, a osservare i feedback, a riconoscere quando un sistema torna in equilibrio (omeostasi) o quando reagisce in ritardo alle nostre azioni (archetipo del ritardo).
Il “metodo al contrario” per la co-creazione dei sistemi informativi
Tiveron propone un’idea interessante: la co-creazione dei sistemi informativi come percorso inverso rispetto al consueto.
Non partire dai dati per arrivare alle informazioni, ma partire dalle informazioni di cui abbiamo bisogno per definire quali dati servono davvero.
È un ribaltamento culturale che richiama da vicino i principi del design thinking e dell’innovazione partecipata: le persone tornano al centro, come parte attiva del processo di apprendimento organizzativo.
Nel suo “metodo al contrario” possiamo leggere un segnale più ampio: l’innovazione, per funzionare, deve tornare a essere un dialogo tra tecnologia e cultura.
Solo così la tecnologia smette di essere una macchina che reagisce e diventa uno strumento che evolve con noi.